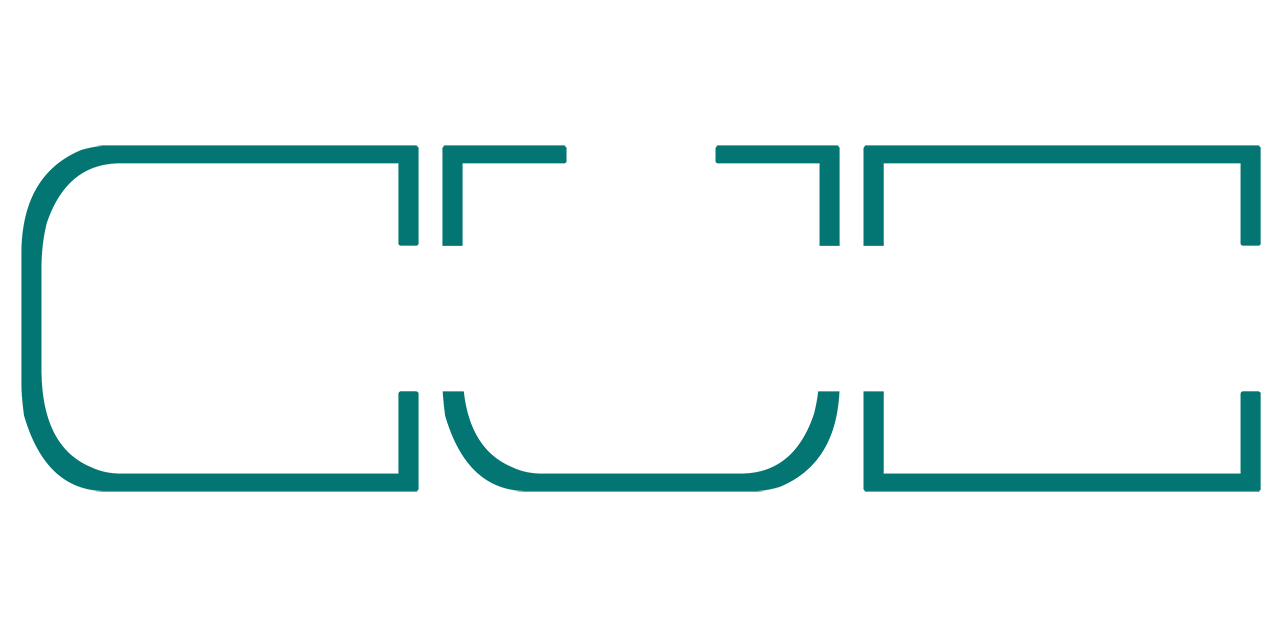Ricerca e PNRR: spesi solo il 44% dei fondi, tra ritardi, squilibri e nuove opportunità

Illustrazione dei fondi per la ricerca (Canva FOTO) - financecue.it
La percentuale dei fondi che sono stati utilizzati sono pochi, ma le problematiche non sono poche. Ma nemmeno le nuove opportunità!
Ogni anno si torna a fare il punto sullo stato della ricerca e dell’innovazione in Italia, e anche stavolta i dati non passano inosservati. Il nuovo rapporto realizzato dal Consiglio nazionale delle ricerche offre una fotografia piuttosto ampia del settore, con luci e ombre che si intrecciano in un momento molto particolare: quello dell’attuazione del PNRR, ormai entrato nella sua fase più delicata.
Tra fondi europei, riforme e aspettative, la domanda di fondo resta sempre la stessa: l’Italia sta davvero investendo in conoscenza o si limita a sopravvivere nel confronto internazionale?
A cinque anni dall’avvio del PNRR, il documento prova a capire cosa ha funzionato e, soprattutto, cosa rischia di bloccarsi senza interventi strutturali. Una delle prime cifre che catturano l’attenzione è legata ai finanziamenti destinati alla Missione 4, quella che riguarda istruzione, ricerca e trasferimento tecnologico: a maggio 2025 era stato speso il 44% degli 8,5 miliardi assegnati.
Accanto ai numeri, emerge anche un elemento quasi paradossale: l’Italia forma talenti, produce idee e tecnologie, ma fatica a trattenerle. La Relazione prova quindi a mettere ordine, dedicando sei capitoli ad aspetti molto diversi fra loro, dal sistema universitario ai finanziamenti, dalla parità di genere nelle carriere accademiche fino alla partecipazione ai bandi europei.
Il quadro generale del sistema ricerca
Come riportato dal comunicato stampa del CNR, uno dei punti centrali del rapporto riguarda gli effetti del PNRR sul mondo della ricerca pubblica. La Missione 4 aveva l’obiettivo di rafforzare il legame fra università, enti di ricerca e imprese, con investimenti che hanno portato all’assunzione di oltre 12.000 nuovi ricercatori, quasi la metà dei quali donne.
Una spinta significativa, che però rischia di rimanere temporanea: senza fondi stabili, gran parte di questi posti potrebbe non sopravvivere alla fine del programma europeo. Il problema, segnalato chiaramente dal Cnr, non è solo economico ma politico: mancano strategie di lungo periodo in grado di assorbire e valorizzare le competenze create durante il PNRR.

Università, brevetti e partecipazione europea
Il documento entra poi nel merito del sistema accademico italiano, sottolineando un distacco sempre più evidente rispetto alla media europea. La spesa pubblica per università e ricerca resta inferiore a quella dei principali partner UE; il corpo docente ha un’età media tra le più alte del continente; l’attrattività internazionale continua a essere debole; e il numero di laureati rimane basso. A complicare il quadro si aggiunge il calo demografico, che non è un dato puramente scolastico, ma un fenomeno che sta ridisegnando l’intero sistema formativo e produttivo.
Il rapporto dedica anche un capitolo al tema dei brevetti: l’Italia mantiene una buona posizione nei settori tradizionali come meccanica e trasporti, ma resta indietro nelle tecnologie emergenti, come intelligenza artificiale, biotech e digitale avanzato. È un ritardo che si collega direttamente alla fuga delle grandi imprese tecnologiche dal territorio nazionale, con una crescente quota di proprietà intellettuale registrata da soggetti stranieri. Una tendenza che, secondo il Cnr, mina la sovranità tecnologica del Paese.